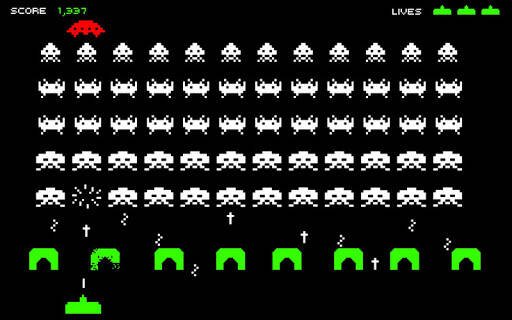Anno domini 2022. Agli inizi di questo mese, quello che sembrava un Pesce d’Aprile orchestrato a regola d’arte si è rivelato un Annuncio in piena regola, uno di quelli che mandano letteralmente in visibilio una robusta generazione di videogiocatori. LucasArts, e più precisamente Ron Gilbert, hanno infatti annunciato Return to Monkey Island. Se siete tra quelli che non hanno idea di cosa stiamo parlando, siete invitati ad andare in piedi dietro la lavagna con un bel cappello con le orecchie d’asino. Possibilmente senza fiatare. Scherzi a parte, Return to Monkey Island è quel gioco che gli appassionati delle avventure grafiche, in particolare di quelle firmate LucasArts, hanno atteso per oltre 30 anni.
Capitolo conclusivo della trilogia originale di Monkey Island e mai ufficialmente pubblicato (quanto meno, non secondo quelli che erano gli intenti narrativi dei suoi autori originali, quali lo stesso Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman), questo gioco in arrivo nel 2022 ha portato molti, in particolare la sottoscritta che firma questo pezzo, a farsi una sola e unica (ma anche provocatoria) domanda.
In un mondo caratterizzato da console di nuova generazione, metaversi e tecnologie d’avanguardia, quanto abbiamo ancora bisogno di avventure grafiche oggi? Inseguiamo, ancora una volta, quel maledetto trend chiamato nostalgia, che fa tanto contenti i vecchi aficionados del videogioco, oppure c’è ancora spazio e margine di manovra per attrarre, soprattutto, un pubblico nuovo?
Certo, le avventure grafiche non sono mai realmente morte nei 30 anni che ci separano dal secondo gioco di Monkey Island di Gilbert-Schafer-Grossman. Anzi, molti studi di sviluppo hanno provato a portare avanti la tradizione nel pieno rispetto di ciò che sono state le avventure grafiche nel corso della storia dei videogiochi, apportando al contempo importanti modifiche e novità al genere con la volontà di ammodernare i suoi stilemi classici.
Ma il fallimento di alcuni sviluppatori che hanno voluto credere nel genere (si vedano i Telltale Games, costretti a chiudere per aver inseguito progetti forse un po’ troppo ambiziosi), così come approcci nuovi come quanto fatto dai Dontnod prima e dai Deck Nine Games poi con la serie Life is Strange (potete recuperarla su Amazon rimasterizzata), ci riportano ancora a quell’insistente domanda iniziale. C’è ancora spazio per le avventure grafiche oggi?
Ma prima di arrivarci, procediamo per step. Proviamo a capire insieme perché questo genere, croce e delizia per i giocatori e gli sviluppatori, è sempre meritevole di un’indagine più strutturata.
In principio fu un genere
Nascere a metà degli anni Ottanta ha significato per tanti di noi appassionati vivere in una sorta di stato di grazia per quanto riguarda il videogioco. C’era voglia di sperimentazione, una volontà ardente di spingere il medium oltre determinati confini dettati non certo per la mancanza di talento o da una pigrizia inconscia degli studi di sviluppo dell’epoca, tutt’altro; quanto piuttosto dai limiti tecnici di cui il videogioco (in quanto mezzo tecnologico) soffriva per ragioni ovvie.
Eppure, proprio quel decennio è stato una fucina fondamentale per cominciare a dare forma a quello che, di lì a poco, sarebbe diventato uno dei prodotti culturali più importanti e innovativi mai realizzati nella seconda metà del Novecento. È proprio in quegli anni, non a caso, che il videogioco inizia a canonizzarsi, a codificare una propria tassonomia. I generi videoludici vengono definiti, si incasellano a poco a poco per permettere agli stessi utenti di essere guidati nella selezione di titoli in base ai loro gusti e alle loro preferenze. Per chi gioca oggi, parlare di platform o FPS – così come di tutte loro infinite ibridazioni – è qualcosa di naturale: è una bussola che ci permette di muoverci agilmente in quel mare magnum che è diventato il medium videoludico nel corso della sua oramai lunga storia.
Ma in quegli anni, in quei gloriosi anni Ottanta, non era altrettanto scontato. Proprio perché gli sviluppatori avevano a disposizione una vera e propria tela bianca da cui partire e, ancora una volta, su cui sperimentare, l’unico limite che avevano – oltre a quello tecnologico, per certi versi – era davvero la loro immaginazione.
Raccontare storie. Fino a poco tempo prima – e pensiamo a titoli iconici come Arkanoid, Space Invaders, Pong, Pac-Man e, perché no, anche il primissimo Super Mario – la narrativa non era lo scopo primario di un videogioco, tutt’altro. Anzi, proprio perché il videogame veniva fruito principalmente nei bar o nelle sale giochi sui cari vecchi cabinati, entrare in partita doveva essere rapido, immediato, senza fronzoli.
Storie povere di contenuto e spesso “stereotipate” (sei un eroe che deve salvare una principessa in pericolo, sei al comando di una navicella spaziale contro un’invasione aliena, e così via), in cui chissenefrega della trama, l’importante è giocare. Un concetto, quest’ultimo, che spesso torna ciclicamente – vogliamo parlare dell’eterna lotta gameplay VS narrazione? Facciamo che rimandiamo il discorso a un’altra volta – ma che ha rappresentato le radici obbligate per il medium dell’epoca.
Eppure, ad un certo punto, raccontare storie è diventato un nuovo obiettivo da conquistare, un nuovo passo che gli studi di sviluppo hanno ritenuto necessario affinché il videogioco uscisse dalla sua staticità di semplice prodotto di interazione uomo-macchina, e offrisse qualcosa di altro. In fin dei conti, i primi anni di quel decennio sono gli stessi che videro la proliferazione di fenomeni quali i libri-game e, ovviamente, giochi di ruolo come Dungeons&Dragons, dove la componente narrativa e la possibilità di espandere i confini dell’immaginazione erano qualcosa di cui i fruitori di quella che poi sarebbe diventato l’emblema della cultura pop sembravano non poterne fare a meno.
E così, a poco a poco, agli albori degli anni Ottanta, iniziano a diffondersi a macchia d’olio le primissime avventure testuali – queste ultime figlie di primi "esperimenti" sul genere condotti già alla fine degli anni Settanta, con prodotti come Colossal Cave Adventure (1976) di Will Crowther o, successivamente, la serie Zork (1979-1982) di Infocom. Non mancano i primi tentativi grafici, ovviamente. Roberta Williams, insieme al marito Ken, sviluppano quella che potrebbe essere definita la prima proto-avventura grafica della storia, con schermate mono-cromatiche: Mystery House (1980) di On-Line Systems. Anzi, a tal proposito vi consiglio la visione della docu-serie targata Netflix, High-Score, in particolare l’episodio 3 dedicato ai giochi di ruolo, con una ricca intervista ai coniugi Williams sulla genesi di Mystery House.
Ma bisogna attendere il 1984 – un anno profetico, se si pensa all’omonima opera letteraria di George Orwell – quando un’ancora acerba Apple lancia sul mercato il Macintosh, il primo personal computer casalingo dotato di interfaccia grafica. Fu proprio a partire da quell’anno, quando la relazione uomo-macchina iniziò a farsi sempre più stretta proprio grazie all’avvento delle interfacce grafiche (un autore fondamentale come Lev Manovich dedica una lunga sezione del suo Il Linguaggio dei nuovi media a questo argomento), che le avventure testuali gettano le basi di quelle che diventeranno quelle che oggi definiamo avventure grafiche.
E proprio quando scrivere comandi di testo o indicazioni per avanzare nella storia comincia a non bastare più, che arrivano i primi tentativi di combinare l’innovazione radicale dell’interfaccia grafica con il testo scritto. Noti anche come "punta e clicca" (oggi usato spesso come sinonimo delle avventure grafiche), questi prodotti iniziano a muovere i primi passi inizialmente su Macintosh con titoli quali Enchanted Scepters e Déjà Vu (1985), sfruttando le caratteristiche peculiari del nuovo personal computer targato Apple.
Tuttavia, bisogna attendere l’anno successivo quando, forte del suo successo cinematografico, la LucasArts (all’epoca ancora sotto l’etichetta di LucasFilm Games) lancia su Commodore64 il tie-in di Labyrinth. L’innovazione di questo gioco sta nella sua stessa struttura in continua evoluzione, che rappresenta anche un primo passo verso quello che sono poi diventate oggi le avventure grafiche. L’opera di LucasFilm Games, infatti, parte come una vecchia avventura testuale per poi dotarsi di un’interfaccia grafica vera e propria, a cui l’utente aveva accesso usando il joystick del C64 per interagire con ambienti e spazi.
Tuttavia, a sancire il successo delle avventure grafiche in senso stretto – probabilmente, a questo punto, ci sarete arrivati da soli – è ancora una volta la stessa LucasFilm Games con quello che, a oggi, rappresenta l’inizio di una vera e propria golden age per il genere: Maniac Mansion del 1987. Il titolo, infatti, decreta in via ufficiale quelli che saranno i caratteri costitutivi dei videogiochi punta-e-clicca dalla fine degli anni Ottanta fino al decennio successivo: tra questi, la possibilità di interagire con l’ambiente tramite l’uso del mouse, selezionare diverse opzioni di dialogo per accedere a maggiori informazioni, accedere a un inventario, risolvere enigmi, accedere a finali multipli in base alle scelte fatte, tanto citazionismo e auto-citazionismo e, ultimo ma non meno importante, una vena comica senza precedenti – talvolta attraverso personaggi assurdi come il demone El Pollo Diablo di The Curse of Monkey Island (1997) o oggetti completamente inutili, come la motosega di Maniac Mansion.
L’umorismo surreale, e talvolta dissacrante, diventa infatti uno dei marchi di fabbrica della LucasFilm Games, che caratterizzerà tutta la loro produzione negli anni a venire. La consacrazione (per lo studio e per il genere) arriva, ovviamente, con The Secret of Monkey Island nel 1990, quando le avventure di un aspirante pirata (totalmente incapace) chiamato Guybrush Threepwood prendono il via nella caraibica isola di Mêlée.
E da lì in poi, la storia delle avventure grafiche si scrive da sola. Oltre al sequel Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991), in quegli anni la LucasArts pubblica alcune dei suoi prodotti migliori: Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992), il sequel di Maniac Mansion intitolato Day of the Tentacle (1993), fino ad arrivare alla prima avventura grafica tridimensionale dello studio – e senza giri di parole, la produzione preferita di chi scrive – Grim Fandango (1998).
Ma sarebbe ingiusto dire che a movimentare la scena delle avventure grafiche di quegli anni ci sia stata solo la LucasArts. A fare concorrenza allo studio, infatti, c’è un’altra azienda altrettanto importante: la Sierra Entertainment, un tempo nota come On-Line Systems (vi ricordate di Roberta Williams?). In parallelo alle creazioni dello studio di Gilbert e compagni, Sierra – attraverso l’inventiva esuberante di Wiilliams – dà vita ad alcune delle saghe più leggendarie della storia dei videogiochi, con un approccio decisamente meno umoristico e più improntato all’avventura a 360°. Tra queste, non si può non menzionare la longeva serie di King’s Quest, che si sviluppa dal 1983 fino al 1998 in otto corposi capitoli, o il più scanzonato Leisure Suit Larry, rivolto principalmente a un pubblico adulto.
Gli anni Novanta vivono di rendita del successo di LucasArts/Sierra e delle importanti innovazioni tecnologiche che fanno capolino in campo videoludico (a partire dai motori grafici) proprio in quel periodo, che rendono le avventure grafiche sempre più affascinanti da un punto di vista prettamente visivo. Sono gli anni di Sam & Max Hit the Road (1993 e 1995 – in questa edizione vengono aggiunti i dialoghi) o del primo Broken Sword (1996), che in qualche modo abbandona in via definitiva lo stile surreale della LucasArts, in favore di avventure ricche di misteri ed enigmi da scoprire, con una grafica squisitamente a cartone animato – e questa volta, anche su console.
Declino e rinascita delle avventure grafiche
Quello che era diventato uno dei generi prominenti sul finire del secolo scorso inizia a mostrare i primi segni di cedimento con l’arrivo del nuovo Millennio. I primi anni 2000 rappresentano, infatti, un periodo di stasi, se non addirittura di declino, per le avventure grafiche, in cui persino colossi come Sierra e LucasArts si vedono costretti a prendere atto della fine di un’era. Insuccessi commerciali e budget troppo elevati mettono in crisi gli studi, portando alla cancellazione di numerosi progetti, tra cui i sequel di Full Throttle e Sam & Max.
Ma il videogioco, si sa, è un medium celebre per la sua plasticità e la sua capacità di adattamento a nuovi scenari. I pubblici stavano cambiando, le opportunità offerte dal videogame stesso (a partire dall’espansione dell’online) davano nuovi impulsi e i tempi erano finalmente maturi per sperimentare un nuovo approccio alle avventure grafiche. A segnare l’inizio della nuova fase del genere è Telltale Games, che, mettendo insieme le lezioni apprese dai grandi studi del passato e introducendo meccaniche prese in prestito dai libri game (e successivamente dalle serie TV), codifica un genere ibrido.
Tales of Monkey Island (2009), The Walking Dead (2012-2018), The Wolf Among Us (2013-2014) sono solo alcuni dei tantissimi franchise a episodi che lo studio sforna soprattutto con gli inizi dei primi anni Dieci del Duemila, canonizzando un modo nuovo di fare avventure grafiche.
Pur mantenendo intatti alcuni capisaldi del genere (interazione con l’ambiente, opzioni di dialogo multiple, finali alternativi, risoluzioni di enigmi), a cambiare in questi giochi sono il mood e la struttura narrativa stessa. Qui, infatti, i Telltale Games attingono a piene mani dalla serialità televisiva, sfruttando espedienti come il cliffhanger (per cui si intende un elemento di forte suspence a fine episodio, atto a trascinare lo spettatore/giocatore ad attendere con impazienza la puntata successiva), personaggi molto complessi (inizia a palesarsi la figura dell’anti-eroe) e un tono narrativo principalmente drammatico. Le scelte del giocatore non sono più solo finalizzate al gameplay in senso stretto, ma lo spingono a entrare in empatia con la storia e i suoi personaggi.
A fare scuola in questo senso, e a espandere ulteriormente il genere in questa direzione più televisiva, è lo studio francese Dontnod. Dopo aver gettato le basi di quella che sarà la mission dello sviluppatore (e dei suoi affiliati) con Remember Me (2013), è con la serie Life is Strange (2015-2021) che le avventure grafiche a episodi danno il via a un percorso inaspettato. Puntando molto sulla componente emotiva – un cambio di passo considerevole, se si pensa allo stile spensierato con cui il genere ha mosso i primi passi – e su un uso studiato della colonna sonora, i Dontnod (così come i Deck Nine Games, che ne hanno raccolto il testimone) hanno intessuto i fili di una nuova fase delle avventure grafiche.
Eppure, per quanto gli sforzi di Telltale e Dontnod siano encomiabili nel provare a dare forme alternative al genere, anche questa fase sembra abbia iniziato un suo declino, nonostante l’entusiasmo iniziale. I Telltale così come li conoscevamo – rei di aver dato luogo a progetti fin troppo ambiziosi e, di conseguenza, con costi insostenibili – hanno chiuso ufficialmente i battenti nel 2018. Dontnod e Deck Nine, dal canto loro, hanno capito che l’approccio episodico al genere, strizzando l’occhio al teen drama, è in grado di intercettare un pubblico troppo ristretto e hanno dovuto, di conseguenza, ridimensionare le loro idee iniziali, per quanto avanguardistiche – si pensi al caso di Life is Strange: True Colors che torna ad un formato a capitoli, rinunciando a quello episodico.
Già, perché il pubblico – divorato dalle pratiche di binge-watching mutuate dalla serialità televisiva delle piattaforme OTT (over-the-top) come Netflix – non è più in grado di “sopportare” lunghe attese tra un episodio e l’altro.
Ed è da qui, giunti alla fine del nostro excursus, che torniamo alla domanda che apre questo articolo: alla luce di quanto ripercorso nelle varie tappe della storia delle avventure grafiche, quanto abbiamo ancora bisogno di un genere come questo?
Non è solo nostalgia
Parecchio. Abbiamo ancora parecchio bisogno delle avventure grafiche, e non solo per soddisfare le esigenze di un pubblico maturo o affezionato, cresciuto a pane e LucasArts/Sierra. Se è vero che la tendenza di molti giochi di genere sia ancora quella di inseguire un glorioso passato (Broken Age di Tim Schafer o Thimbleweed Park di Ron Gilbert e Gary Winnick ne sono un valido esempio), il mondo delle avventure grafiche è ancora un terreno meritevole di esplorazione, anche in ottica di un ampliamento massiccio del pubblico di videogiocatori cui si è assistito negli ultimi anni.
In questo senso, Return to Monkey Island rappresenta un caso interessante da monitorare nei prossimi tempi. Se gli stessi Broken Age e Thimbleweed Park hanno comunque riscosso un buon responso da parte della critica e dei fan incalliti, hanno comunque fallito nell’accaparrarsi il pubblico "largo" dell’oggi, in tutte le loro sfumature. L’errore da evitare, appunto, sarebbe quello di concentrare tutti gli sforzi di questa operazione in un copia-e-incolla di quanto fatto in passato, e in alternativa trovare modi innovativi per conquistare un’utenza sempre più volubile e affamata di novità.
Paradossalmente, ciò che auspico è un ritorno concettuale a quella voglia di sperimentazione che ha contraddistinto i primi anni Ottanta e, di conseguenza, le prime avventure grafiche. In parte, i Telltale e i Dontnod hanno dato un assaggio delle potenzialità ancora sottese al genere, senza mai snaturare i caratteri costitutivi che lo hanno canonizzato in questi oltre 40 anni di storia. Cambiare forma e mantenerci coinvolti, perché è ciò che il videogioco in quanto medium ha sempre fatto e continua a fare nella sua lunga esistenza.
In parte, i walking simulator (così odiati, ma al contempo così giocati) hanno raccolto l'eredità delle avventure grafiche e hanno iniziato a tracciare una linea di demarcazione abbastanza importante in questa direzione, se ci pensiamo. Tuttavia, anche questi titoli – un po' come l'epoca segnata dai Dontnod e Telltale – rimandano ancora una volta a quella dimensione emozionale, a volte sfociando nel filosofico e politico con eccezionali risultati (si pensi a prodotti come Everybody's gone to the Rapture di The Chinese Room, Firewatch di CampoSanto o ancora The Stanley Parable di Galactic Café, per citarne un paio)
Return to Monkey Island sarà un banco di prova importante per la tenuta del genere delle avventure grafiche nel prossimo futuro. Senza essere eccessivamente catastrofisti o entusiasti, i tempi sono di nuovo maturi per ripensare e far evolvere il genere. Ancora e ancora.
Anche solo per concepire qualcosa di analogamente sopra le righe come i "duelli di insulti" dello stesso Monkey Island, o qualcosa di profondamente toccante come i due finali potenti del primo Life is Strange.
Il videogioco è un medium vivo: nutriamolo di idee.
Testi di riferimento e letture consigliate:
Barra, M., «Game Series: Il linguaggio seriale nel mondo videoludico», in Mediascapes Journal, n. 7, 2016Bruun Vaage, M., The Antihero in American Television, Routledge Advances in Television Studies, Londra, 2015Kalata, K. (a cura di), The Guide to Classic Graphic Adventures, 2011 (formato Kindle)Malgieri F., «Giocare a puntate. Le nuove forme seriali del videogioco tra letteratura e televisione» (pp.127-140), in Cardini D. (a cura di), Testo a Fronte – Teoria e pratica della traduzione, n. 59 – Milano, II semestre 2018Manovich, L. Il Linguaggio dei nuovi media, Edizioni Olivares, 2001Costrel F., High-Score, Netflix, 2020