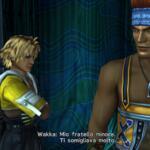Attenzione! Questo video articolo contiene spoiler da Final Fantasy X.
A fine febbraio 2020 è stato chiesto quale fosse il Final Fantasy preferito dal pubblico giapponese: la vittoria è andata (forse un po’ a sorpresa) proprio al decimo capitolo della saga. Un giudizio particolare, considerando appunto gli sforzi di Square-Enix con il remake del settimo capitolo. Oggi, però, non vogliamo interrogarci su quest’ultimo, ma appunto indagare su come mai Final Fantasy X sia ancora così amato.
Final Fantasy X, o “non si torna più indietro”
Final Fantasy X fu, per molti punti di vista, sia il momento più alto che il punto di non ritorno per Squaresoft/Square Enix. Costato 4 miliardi di yen (corrispondenti grossomodo a una trentina di milioni di euro) e sviluppato da un centinaio di persone, era l’esordio della saga sulla neonata PlayStation 2. Per farlo si decise di creare il più spettacolare e visionario videogioco di ruolo alla giapponese mai visto. Un’impresa che è riuscita, ma nel modo più paradossale di tutti: in un’industria che andava muovendosi sempre di più verso il mondo aperto in cui azione ed esplorazione si intersecassero senza soluzione di continuità, l’opera recuperò la tradizione dei turni e una trama lineare.
Proprio per questo l’accoglienza forse fu meno “calorosa” rispetto a quella che era stata riservata ai suoi fratelli per la prima PlayStation. Per quanto ne furono riconosciuti i meriti, quello che gli si rimproverava era sia il suo essere “troppo simile” ai predecessori che di essere “tornato indietro” anche a livello di sistema e ambientazione, nella sua decisa linearità.

Di nuovo, era tutto vero ma allo stesso tempo in pochi capirono come tutto questo fosse in realtà funzionale proprio a quello che Final Fantasy X voleva fare: raccontare una storia. Una medicina amara che si nasconde sotto il “miele” dei tratti pastello e qualche buffa scenetta, ma che in realtà mette in campo temi difficili, pesanti, che fanno sentire a disagio. La storia di Final Fantasy X è un poema epico che parla di peccato, paura, amore, vendetta, politica, rapporto col divino, figure genitoriali, passato e redenzione, fino alla morte stessa: non è mai stato ammesso esplicitamente, ma è palese come tutto Final Fantasy X sia prima di tutto una riflessione sulla morte e dell’inquietudine che (a causa della sua intrinseca imperscrutabilità) suscita nell’essere umano.
C’è del marcio a Spira
L’ultima grande opera di Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase, Nobuo Uematsu e dei loro collaboratori è un poema epico non solo per il suo ampio respiro e la tensione verso la “grande impresa”, ma perché prima di tutto mette al centro della storia l’essere umano, in ogni sua sfaccettatura grande e piccola, elevata e bestiale. Ne evidenzia le infinite potenzialità derivate dal suo poter immaginare l’infinito pur non potendolo raggiungere, e della sua capacità di realizzare l’impossibile, fosse anche tirare giù gli dèi dai loro troni. A partire anche dai sette eroi: Tidus lo sportivo che da irresponsabile realizza il proprio scopo, Yuna che porta avanti il suo dovere nonostante sappia il destino infausto che la attende, Auron il severo mentore in cerca di redenzione, Kimahri il guardiano silenzioso, Lulu la cinica ma empatica maga, Rikku l’enfant prodige. E infine Wakka, che da bacchettone tecnofobico e un po’ razzista cambia radicalmente quando insieme ai suoi compagni porta a galla il marcio della classe clericale e dello stesso culto di Yevon.

-
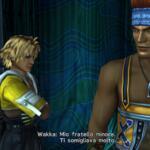
Il “grande nemico” Sin passa quindi da minaccia da sconfiggere a vero e proprio mezzo di legittimazione di un governo e tradizioni tecnofobici. In effetti, tutta Spira si regge sulla paura e sui paradossi. Le “anime smarrite” che non vengono trapassate diventano mostri (che in inglese sono chiamati fiend, che vuol dire sì “demonio” ma anche “persona maligna” e “invasato”), le manifestazioni sportive (in questo caso il blitzball) usate come “sedativo” per le masse ottenebrate da un “peccato originale” che le potrebbe distruggere in qualsiasi momento, lo sfruttamento di macchine e tecnologia da parte di quella stessa classe dirigente che dice di odiarle.
Oltre il buio e il dolore
Tidus capirà solo più avanti che il pellegrinaggio in cui sta accompagnando Yuna è in realtà un viaggio verso la morte, in quanto l’Invocazione Suprema e la sconfitta di Sin si pagano con la vita. Il momento in cui Tidus realizza tutto ciò rimane ancora tra le sequenze di maggior impatto emotivo della sesta generazione, così come lo è il momento (ben più famoso) del loro primo bacio. In quella breve pausa in cui Yuna scoppia in lacrime perché non può che portare avanti delle sue credenze, pure se le ha letteralmente viste diventare cenere tra le dita, Tidus fa l’unica cosa veramente sensata: ricordarle che alla fine ci sono cose più grandi e più belle, e che nel buio più totale una fiamma di candela illumina più del sole.

-

Sarà lei a rivelare la terribile verità al gruppo, così come lei è simbolo della seconda ribellione al sistema: dopo il clero corrotto, con la sua morte e la perdita della possibilità di ottenere l’Invocazione Suprema Tidus, Yuna e i loro compagni mettono in discussione il falso ordine di un uomo che ha cercato di essere un dio ed è diventato solo un parassita. Abbattendo Yunalesca i nostri sette eroi realizzano che, sacrificando Yuna, sarebbero solo scappati dal dolore o peggio l’avrebbero solo rimandato. Si può scegliere di fuggire dal dolore e far finta che non esista, oppure si può rimanere ad affrontarlo. Il dolore odia il coraggio, se ne sente sminuito: perché sa benissimo che appena la vittima non scappa, ecco che improvvisamente lui perde tutto il suo potere.
Final Fantasy X, letteralmente
C’è però un significato più nascosto nella storia di Tidus e Yuna. Il loro pellegrinaggio per una breve pace (pagata carissima) che si trasforma in crociata per sovvertire il sistema tutto è infatti una interpretazione letterale del titolo Final Fantasy. Il “prodigio” degli Intercessori (Fayth) sta appunto nella loro capacità di manifestare, attraverso il proprio sognare, entità eterne chiamate Eoni. Queste sono appunto delle incarnazioni (avatara è termine sanscrito che nell’induismo indica appunto la divinità che si incarna sulla terra per ristabilire l’equilibrio) e hanno poteri immensi, oltre a non essere suscettibili alla morte.

Gli Intercessori possono concedere questa loro capacità agli invocatori che reputano degni, in modo che possano imparare a comandare tali loro manifestazioni e, a tempo debito, richiamare un Eone sufficientemente potente (appunto l’Eone Supremo) che possa essere usato dallo spirito di Yu Yevon come mezzo per rigenerarsi.
Gli Intercessori sarebbero quindi dei veri e propri catalizzatori di energia magica, che attraverso il loro sognare hanno il potenziale per far avverare qualunque prodigio. In questo senso gli stessi Jecht e Tidus assurgono a sorta di “Eoni apocrifi”, in quanto esistono su Spira come “sogni” degli Intercessori stessi. Tidus in particolare è stato “creato” dagli Intercessori apposta come strumento per “spezzare il ciclo” e ottenere una morte prima temuta ma adesso desiderata, avendo scoperto la vuotezza del rimanere bloccati nel sogno. Quando Sin viene trapassato e svanisce, gli Intercessori finalmente si risvegliano e si dissolvono a loro volta, facendo quindi “scomparire” la magia dal mondo. In questo senso anche l’umanità si risveglia dal circolo vizioso in cui era stata intrappolata per mille anni: Tidus e la sua avventura sono state letteralmente la loro “ultima fantasia”.

“Piangerai. Stai per piangere. Piangi sempre. Vedi? Stai piangendo anche adesso!”
Final Fantasy X assume quindi le vesti non solo di morale e riflessione, ma anche di punto di incontro tra il passato e il futuro. La serie si era da sempre contraddistinta nel mondo occidentale per proporre un originale e caratteristico “miscuglio” tra magia e tecnologia, ma per loro stessa natura questi due concetti non possono convivere a lungo: piuttosto la “scomparsa della magia” diviene spesso metafora di “fine dell’ingenuità”. Perché Tidus e Yuna sono entrambi, a modo loro, irrazionali: Tidus è uno sportivo che vive troppo leggero, quasi vive “di pancia”, mentre Yuna deve fare i conti con il carico morale della fiducia in lei riposta da tutta Spira. Per questo i due sono sulla stessa lunghezza d’onda, e il legame che stringeranno darà loro la forza di volontà per andare fino in fondo: Tidus si sbaglia, non è la “sua”, ma la “loro” storia.
Una relazione fatta di non detto, dello scegliere di portarla avanti pur avendo capito che non ci sarebbe stato futuro, perché appunto Tidus è legato al sogno degli Intercessori e svanirà insieme a loro, insieme a Sin, a Yu Yevon e a tutto il male che questo ha portato. Un finale dolce ma amaro, terribile ma giusto. Dopo aver concluso la sua missione da eroina, Yuna ritorna umana quando si oppone all’ineluttabile, comprendendo che pagherà la salvezza di Spira con un vuoto incolmabile. Quando cerca di abbracciare Tidus solo per attraversarlo e cadere perché ormai lui non è più solido, sta svanendo insieme al suo sogno di Zanarkand, quando si rialza e gli confessa il suo amore, quando lui non può che abbracciarla, grato. E lì, in quel momento, il mondo ha pianto.